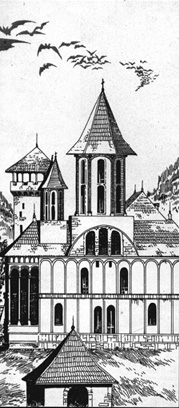 |
Approssimativa
ricostruzione del castello di Dracula eseguita seguendo le
tracce di documenti dell'epoca.
Fonte: Corriere della Paura n. 1 - 1974 |
In un cantone dell’Ungheria, nella prima metà
del ‘700, un contadino di nome Arnold finì stritolato sotto un carro di
fieno. Un mese dopo, quattro paesani morirono fulmineamente della morte orribile
di coloro che, secondo la tradizione dei luoghi, vengono dissanguati dai
vampiri. Scattò l’allarme, vennero riesumati alcuni cadaveri di recente
sepolti. Fra questi, quello di Arnold che recava inconfondibili le note
caratteristiche del vampirismo. Il corpo era fresco, integro, non recava traccia
di decomposizione; i capelli, le unghie, la barba erano cresciute, le vene piene
di sangue fluente che inondava il lenzuolo in cui era stato avvolto alla
sepoltura. Un magistrato, al cospetto del quale l’esumazione era avvenuta,
ordinò che venisse immediatamente piantato un paletto appuntito nel cuore di
Arnold: dal corpo partì un grido straziante, come fosse stato in vita. Poi fu
decapitato e dato alle fiamme: così, del vampiro, non si sentì più parlare…
Questa e decine di altre analoghe cronache si possono leggere nell’opera che
l’abate Dom Augustin Calmet pubblicò nel 1749, dal titolo «Dissertazioni
sulle apparizioni degli spiriti e dei vampiri», in cui sono raccolti numerosi
racconti, molti dei quali inediti, di apparizioni e incursioni vampiresche in
paesi dell’Europa centro-orientale. Questa macabra figura fu introdotta nella
cultura dotta dell’occidente verso il 1600, da alcune relazioni di viaggio in
Grecia e nei Balcani: ma sarà nel ‘700, secolo diviso fra razionalismo e
mistero, illuminismo e tradizioni occulte che il vampiro diventerà un
personaggio, o un incubo se vogliamo, per gli europei occidentali. Voltaire
osservò che fra il 1730 e 1735, non si fece altro che vedere vampiri. Non si
trattava, però, solo di una moda del secolo, perché il vampiro è molto più
antico.
Ne parlano documenti dell’antica Cina, di babilonia, Caldea, Assiria, Egitto.
In una tavoletta di scongiuri proveniente dalla biblioteca di Ninive, la
tredicesima formula insegna a combattere «il fantasma, lo spettro, il vampiro».
La credenza che il corpo di un morto possa desiderare il sangue è presente
anche fra i greci: in «Ecuba», Euripide rappresenta Achille nel suo sepolcro,
placato dal sacrificio di una vergine di cui beve il sangue. E un vampiro,
secondo le cronache dell’epoca, fu esorcizzato dal grande mago Apollonio di
Tiana, contemporaneo di Cristo.
una tradizione, comunque, tipica dell’oriente europeo, dal quale proviene lo
stesso nome: vampyr in magiaro, upiery in polacco, upiry in
russo. «Si dettero questi nomi – scrive Collin de Plancy nel suo celeberrimo
«Dizionario infernale» - ad uomini morti e seppelliti da parecchi anni o
almeno da parecchi giorni, i quali si facevano vedere in corpo ed anima,
parlavano, camminavano, succhiavano il sangue dei lor parenti, li sfinivano ed
infine lor cagionavano la morte. Non si troncava il corso delle loro visite e
delle loro infestazioni che dissotterrando i cadaveri, impalandoli, tagliando
loro la testa e bruciandoli… i giornali di Francia e dell’Olanda parlarono
dal 1693 al 1964 di vampiri che si mostrarono in Polonia e soprattutto in Russia».
A dimostrazione di come il fenomeno fosse preso tremendamente sul serio, dal
Medioevo in poi in questi paesi, non stanno soltanto l’imponente numero di
cronache e tradizioni, ma anche le complesse pratiche magiche e rituali, nonché
i provvedimenti giuridici volti a difendere la comunità dall’attività del
vampiro.
Non è un caso quindi che l’irlandese Bram Stoker, padre del più celebre
vampiro della cultura moderna, avesse ambientato in Romania e segnatamente sulle
montagne della Transilvania il romanzo «Dracula» (1897) che originò una
rinascita del genere vampiresco, che dura ai giorni nostri grazie anche a
capolavori cinematografici come «Nosferatu» di Mornau del 1922 e «Vampyr» di
Dreyer del 1932
|
Commenti
Posta un commento